Il Redentore

Si deve a Gustavo Frizzoni l’aver fatto conoscere questa tavola che all’ora si trovava a Modena nelle mani di Matteo Campori. Questi l’aveva ottenuto, grazie all’antiquario Foresti dalla Congregazione di Carità di Correggio che l’aveva imprudentemente venduta nel 1914 (Campori 1924, pp. 23-24). Al momento della pubblicazione la tela che presentava molte lacune era stata restaurata a Milano da Carlo Moroni (1982-1939) (Frizzoni 1916, p. 65), uno dei numerosi artigiani della rovina di questo capolavoro.
L’istituzione caritativa di Correggio grazie a un processo giunse a recuperare la tavola nel 1917. Fino al 1997 rimase proprietà delle Opere Pie Riunite di Correggio per poi essere acquistata dal Comune di Correggio. In data ignota questa tela era giunta in possesso della Congregazione di Carità grazie al legato di Caterina Contarelli che era morta senza eredi nel 1851.
Si ignora come la tavola del Mantegna fosse giunta nelle collezioni della famiglia.
Si è supposto, a partire da Bertolini (1930, p. 41-43), ma senza alcuna prova che dopo l’espulsione del principe Giovanni Siro nel 1635 e la conseguente annessione di Correggio al Ducato di Modena, il dipinto sia stato ceduto a Giulio e Francesco Contarelli, antichi amministratori del principe. In effetti nell’inventario dei beni di Francesco Contarelli, redatto nel 1697 figura, ma senza indicazione d’autore, “ Un quadretto piccolo con cornici con l’effigie del salvatore”. Tuttavia nessun’opera di questo genere figura tra i beni dell’ultima Contarelli (Lusetti e Pratissoli 1995, p. 65).
Benché la tela sia firmata, la proposta di Frizzoni incontrò una certa ostilità, percepibile fin dalla prima delle numerose esposizioni alle quali il dipinto ha partecipato. Una tendenza che conferma la sua assenza ripetuta dalle liste di Berenson (non doveva apparire che nelle liste postume) e il suo rigetto da Erica Tietze-Conrat.
Dopo il restauro effettuato da Renato Pasqui nel 1959 e la difesa che ne fece all’ora Augusta Ghidiglia Quintavalle, l’opera entrò definitivamente nel corpus delle creazioni autografe di Mantegna.
L’immagine, eseguita a tempera a colla su tela di lino ha molto sofferto: è stata improvvidamente verniciata a più riprese anche in epoche recenti. Molti dei dettagli che caratterizzano per esempio l’essenziale delle lettere pseudo-cufiche dorate che figurano sul bordo della veste moiré di Gesù, sono andate perdute. Molto spesso come in opere destinate al grande pubblico il quadro è rappresentato senza la sua inquadratura in prospettiva, cosa che ne falsa la comprensione.
Sul bordo rosso, leggermente irregolare che ricorda quello del Cristo che porta la croce di Verona molto più tardi, appaiono, in lettere d’oro, delle inscrizioni in eleganti capitali umanistiche che si sono conservate solo parzialmente.
Sul lato sinistro, dove i caratteri sono disposti verticalmente, con numerose lettere girate a 90 gradi, secondo un procedimento che Mantegna utilizza all’ora, si legge oggi Momordite vos met ipsos ante effigiem vultus mei.
La MO iniziale di momordite è un’invenzione moderna (come testimonia il tracciato differente delle lettere confermato con un esame con la lampada di Wood) che risale senza dubbio al restauro di Carlo Moroni. Questa forma di imperativo, con il raddoppio di una parte del radicale, non ha del resto alcun senso in latino, tanto che mordite, per la forma corretta mordete è, come mi segnala Gianfranco Fiaccadori, “un solecismo accettabile, il risultato di un banale metaplasmo, tra la seconda e la terza coniugazione ( e chi, mal comprendendolo avrà suggerito all’ora l’aggiunta di MO)”.
Qui si ha una esortazione diretta del Signore agli spettatori (il verbo al plurale lascia intendere che ce ne sia più d’uno) che bisogna leggere come complemento di quella che figura sulla copertura del libro rosso, rilegata con dei cabochons metallici, posta tra le mani di Cristo: “Ego sum. Nolite timere”. Quest’ultima frase fa eco a due affermazioni del Vangelo: Gesù che si rivolge agli apostoli stupefatti che lo vedono camminare di notte sulle acque del Mare di Galilea (Mt, XVI, 27; MC, VI, 50; Gn., VI, 20) o che rassicura gli apostoli riuniti ai quali appare dopo la Resurrezione (Lc, XXIV, 36).
Sul bordo inferiore del lato corto una lunga iscrizione latina, mutila e molto rovinata, la cui lettura è controversa, con delle lettere separate da un elemento in forma di piccola Hedera Distinguens (che Mantegna utilizzò ancora).
Ad oggi l’interpretazione più convincete è la seguente: “ [And(reas) Mantin]ia p. c. s. d[ono] d[edit] MCCLXXXX[III] d [ie] // V // IA [NUARII]”.
La decifrazione di certe abbreviazioni non è unanime il gruppo p.c.s. venne interpretato da Frizzoni (1916, pp. 67-68) come P[ICTOR] C[HARITATE] S[VA]. Lo stesso Frizzoni propose come possibile lettura del d.d. seguente D[OMINO] D[ICAVIT], da cui l’idea, che conobbe un grande successo, che il quadro sia stato fatto per un dominus, forse di Correggio.
Lightbown (1986, p. 437) propose di interpretare p.c.s. come P[ALATINUS] C[OME]S, titolo del quale Mantegna si fregiò dal 1469 e che utilizzò anche per contrassegnare altre opere (ma sotto la forma comes palatinus). La presenza dell’hedera tra c ed s, essa stessa un’abbreviazione, impedisce in ogni modo di accettare questa lettura.
Per Lusetti e Pratissoli (1995, pp. 65-66) la S significherebbe S[PONTE] dopo un esame attento dell’opera e l’apporto decisivo della lampada di Wood, Fiaccadori lascia intendere che la lettera reintegrata come C possa essere stata inizialmente una O, alla quale il disegno delle tracce originarie corrispondono meglio. Da cui P.O.S. che si potrebbe leggere come P[IETATIS] O[PVS] S[VIS] o, meglio ancora P[RINCIPI] O[PTIMO] S[PONTE] seguito certamente da D[ONO] D[EDIT].
Un regalo dunque dell’artista “ai suoi intimi come opera di devozione “ o più semplicemente a un “Signore” non dichiarato. L’iscrizione ci informa in ogni modo sulla data – 5 gennaio 1493, un Sabato, giorno della festa di San Telesforo nella quale l’artista ha donato l’opera ad un destinatario sconosciuto.
Il Cristo di Correggio è una tavola di devozione privata dotata di una potenza emozionale intensa che non sembra interessata dalle ricerche sui fenomeni sentimentali sui quali si impegnano le avanguardie della pittura italiana della fine del ‘400 deve essere interpretato in parallelo con i personaggi delle grandi tavole degli anni 1490, le vergini per Santa Maria in Organo a Verona (1493-1497) e Santa Maria della Vittoria a Mantova.
La piccola tavola non è una Imago pietatis, non si tratta né di un Salvator mundi né di un Redentore benedicente: il Cristo è rappresentato senza piaghe, senza stigmate, senza corone di spine, senza che le sue sofferenze siano esibite. Questo Gesù molto affaticato col viso contornato di un alone luminoso che si illumina in tre punti di raggi più vivi a suggerire la forma di una croce, è in preda a una melanconia mortale che “vela ( ma non fa che offuscare) l’ossessione glittica” di Mantegna (Longhi 1962, p. 154).
E ancora: “si direbbe una Veronica ottenuta applicando lino del supporto su qualche basso rilievo della romanità più tardiva, la più attenuta e la più stanca” (Testori 1984, p. 3).
Traduzione della scheda di Giovanni Agosti in Mantegna 1431 – 1506, sous la direction de Giovanni Agosti et Dominique Thiébaut, Paris, Musée de Louvre, 26 septembre 2008 -5 janvier 2009, Paris 2008, pp. 300-302.
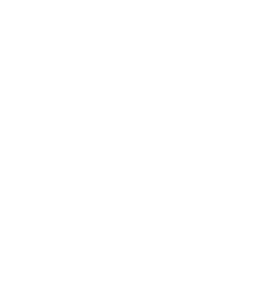 Museo Il Correggio
Museo Il Correggio 