Giuliano e Lorenzo de’ Medici, Signori di Firenze
Giuliano de’ Medici nacque il 25 marzo 1453 a Firenze in una delle famiglie italiane di maggior livello sociale dell’epoca, figlio di Piero il Gottoso e Lucrezia Tornabuoni. Cresciuto nella raffinata atmosfera della nobile corte medicea, ricevette un’educazione umanistica di altissimo livello, basata sugli insegnamenti di filosofi e intellettuali del Rinascimento. La sua formazione includeva letteratura, filosofia, arti e strategia politica, rendendolo un perfetto esempio dell’ideale del principe rinascimentale.
A differenza del fratello maggiore, Lorenzo il Magnifico, che si dedicava intensamente alla politica, Giuliano mostrava un carattere più libero e amante dello sport, della caccia e delle arti. Era noto per il suo fascino, il suo spirito cortese e la sua abilità nelle giostre cavalleresche, qualità che lo resero una figura molto amata dai fiorentini.
Dopo la morte del padre nel 1469, Giuliano e Lorenzo assunsero congiuntamente il controllo della Signoria di Firenze. Sebbene il governo fosse ufficialmente repubblicano, i due fratelli esercitavano il potere con abilità diplomatica e senza un titolo formale. Giuliano si occupava principalmente di questioni militari e di rappresentanza, lasciando a Lorenzo la gestione più diretta degli affari politici.
Uno dei momenti più celebri della sua vita fu la sua partecipazione al Torneo Cavalleresco di Santa Croce del 1475, un evento grandioso organizzato da Lorenzo. Giuliano vinse la giostra e dedicò il suo trionfo alla bellissima Simonetta Vespucci, musa di Sandro Botticelli, che la ritrasse come Venere nella celebre “Nascita di Venere” e in altre opere.
Nonostante il prestigio e il potere della famiglia de’ Medici, Firenze era attraversata da tensioni politiche. Il crescente dominio di Lorenzo aveva attirato l’inimicizia di alcune famiglie rivali, in particolare i Pazzi, una delle casate più influenti della città. Di conseguenza, con l’appoggio del Papa Sisto IV e di suo nipote Girolamo Riario, i Pazzi ordirono una congiura per eliminare i Medici e prendere il controllo della città.
Il 26 aprile 1478, durante la messa solenne nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la congiura venne messa in atto. Mentre il sacerdote alzava l’ostia, i sicari attaccarono contemporaneamente Lorenzo e Giuliano. Lorenzo riuscì a salvarsi con una ferita alla spalla, trovando rifugio in sacrestia, ma Giuliano non ebbe la stessa fortuna. Fu colpito con 19 coltellate da Francesco de’ Pazzi e Bernardo Bandini Baroncelli, morendo sul pavimento della Cattedrale. La sua morte scatenò una feroce reazione popolare: i cittadini fiorentini, fedeli ai Medici, si riversarono nelle strade in cerca di vendetta. I congiurati furono catturati e giustiziati quasi immediatamente.
Dopo la sua morte, Giuliano divenne una figura mitizzata nel panorama culturale fiorentino. Botticelli, Michelangelo e altri artisti rinascimentali lo celebrarono nelle loro opere, mentre il fratello Lorenzo lo onorò con monumenti e commemorazioni.
Nel 1520, il nipote Papa Leone X (figlio di Lorenzo il Magnifico) commissionò a Michelangelo la realizzazione della sua tomba nella serie di Cappelle Funerarie della Famiglia de’ Medici all’interno della Sagrestia Nuova della Basilica San Lorenzo a Firenze (passate alla storia come Tombe Medicee). Qui Giuliano è raffigurato come un condottiero romano, con un’espressione fiera e contemplativa. Ai suoi piedi si trovano le celebri allegorie del Giorno e della Notte, simboli della transitorietà della vita e della memoria eterna.
Nonostante la sua breve vita, Giuliano de’ Medici lasciò un segno indelebile nella storia del Rinascimento. Il suo spirito cavalleresco, la sua passione per le arti e la sua tragica fine lo resero un’icona della Firenze medicea. Il suo sacrificio rafforzò il potere dei Medici, che dopo la Congiura dei Pazzi consolidarono il loro dominio su Firenze, trasformandola nel centro culturale e artistico più importante dell’epoca.
Per quanto riguarda Carmela Adani, forte ammiratrice di Michelangelo, decise di riprodurre svariati disegni (presente qui in mostra anche il disegno di “Mosè” celebre scultura marmorea raffigurante il patriarca biblico nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma) prendendo spunto, in questo caso, dalle Tombe Medicee, in particolare scegliendo Giuliano de’ Medici come personaggio protagonista, e ispirandosi all’arte del Buonarroti.
Ultimo aggiornamento
15 Aprile 2025, 16:05
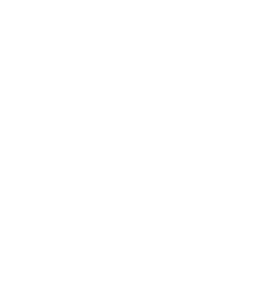 Museo Il Correggio
Museo Il Correggio 